Ali di farfalla
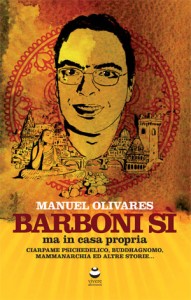 Un racconto, presentato su questo blog in tre puntate, inserito nella raccolta Barboni sì ma in casa propria. Per leggere la seconda parte, cliccare qui! Per leggere la terza, cliccare qui!
Un racconto, presentato su questo blog in tre puntate, inserito nella raccolta Barboni sì ma in casa propria. Per leggere la seconda parte, cliccare qui! Per leggere la terza, cliccare qui!
L’hostél della compassione (giugno 2007)
Entrò nella mia vita quasi in punta di piedi. Con “buongiorno” e “buonanotte” sullo schermo del telefonino. Erano brevi messaggi intercontinentali che, con il fuso orario, arrivavano ad ore insolite. I messaggi di buongiorno giungevano alle 5 o alle 6 del mattino, quando ero ancora immerso nel sonno. Ero ospite a Christiania in quel periodo, la più grande comune urbana d’Europa, alla periferia di Copenaghen.
I messaggi arrivavano dall’India, dove avevo trascorso l’inverno e ci eravamo conosciuti.
Con l’incedere delle settimane e dei mesi si intensificarono, acquisendo venature tenere ed audaci.
Mi seguirono nei miei diversi spostamenti europei, a Londra, in Italia settentrionale, in Italia centrale, fino a quando ci incontrammo di nuovo e trovammo la forza di sfidare una cultura.
È passato circa un anno dai miei risvegli teneri a Christiania, lei si è messa quasi comoda al mio fianco e siamo in viaggio, oberati di bagagli, primi aggregati di un progetto comune.
Kathmandu ci ha accolti in una giornata assolata che quasi stemperava il languore dei tetti di lamiera tenuti fermi con grossi sassi, le impurità dei combustibili di scarto, il traffico caotico e prevaricatore.
A Kathmandu abbiamo vissuto più di due settimane in un albergo quasi lussuoso dove abbiamo strappato un prezzo ragionevole dato l’imminente arrivo dei monsoni.
La nostra stanza conservava il sole che ci ha accolti al nostro arrivo, quando sistemarono alla meglio i nostri tanti bagagli nel cofano e sul tetto di una vecchiacadente fuori-serie bordeaux.
Ora illanguidisce l’anima all’idea di Kathmandu, forse piccola Parigi d’Oriente, con i suoi rikshaw-wallah disonesti, la sua povertà pudica ed un po’ elusa ai nostri occhi, la sua dimessa, nonurlata santità, la sua patetica dissoluzione.
Abbiamo fatto sobriamente festa a Khatmandu, nell’illusione di una quasiricchezza un po’ coloniale, fatta di colpetti alla nostra porta, vassoi di colazione e cena in camera. Abbiamo riempito la nostra stanza di gemiti ed odori di umori sessuali, dei respiri forzati e poderosi del pranayama, di mantra di fronte alla sacra famiglia di Shiva, Parvati e Ghanesha.
Illanguidisce l’anima innanzi a una finestra su un brandello di vegetazione tropicale, mentre arrivano le chiacchiere discrete dei camerieri di fianco ad una modestissima sala da pranzo.
Pokhara, la seconda città del Nepal, ci ha accolti in pieno monsone.
Il vecchio autobus è approdato nel parcheggio semideserto della stazione.
Siamo scesi sotto la pioggia impietosa e, dal tetto, un ragazzo ossuto ci ha passato i nostri tanti bagagli.
Abbiamo intimato al tassista di portarci al nostro ostello-albergo, che avevamo già prenotato e dunque abbandonasse subito l’idea di portarci all’hotel che gli avrebbe dato la commissione.
Siamo giunti di fronte ad un francobollo di giardino ad aspettare un bambino appena cresciuto, Deepak, venirci incontro e scaricare le valige.
Il posto è un ostello con qualche pretesa di hotel.
Lo chiamerò un hostél, anzi “l’hostél della compassione”.
Il giorno dopo, difatti, troviamo già di meglio. Una bella stanza, per appena 100 rupie in più, con lavandino marmoreo, salottino, bel letto matrimoniale e televisione. Sobala ha bisogno, ogni tanto, di sintonizzarsi sui canali della tv indiana, abbastanza accessibile dal Nepal, di canticchiare i mantra mattutini o sentire una delle tante prediche dei diversi guru mediatici.
Io in quei momenti tendo ad assentarmi, ad andare con la mente ad una delle mie ossessioni e lei canticchia in camicia da notte bianca e mi arriva, a leggere ondate, il suo odore forte, di pelle scura, colore del chai.
Nel nostro hostél non c’è televisore e tutto quanto contribuisce a tirare le fila di un lungo racconto di una miseria sostanzialmente accettabile (è forse questa la cosa più inquietante; la miseria clamorosa, insopportabile, può quantomeno innestare sani propositi di fuga), di uno squallore subdolo che si insinua a tutte le ore tra le pieghe dell’anima come tarlandola.
Dicevo che per appena cento rupie in più potremmo avere di molto meglio e tuttavia Sobala insiste a non volersi muovere.
Io tendo ad attribuire la cosa ad una sua endemica pigrizia ma mi sto sbagliando.
Siamo in una barchetta sul Phem Tal, il lago placido della città, lo scenario di molti viaggi acidi della stagione hippy che ha avuto, qui, uno dei suoi giardini dell’Eden. Dietro di noi un barcaiolo sdentato rema tre volte a destra e tre a sinistra.
Ripenso a Deepak, alla sua crescita stentata, al suo aggirarsi timido ai suoi stessi occhi nello squallore subdolo dell’hostél.
In questi giorni siamo forse gli unici clienti ed abbiamo l’hostél quasi tutto per noi, con i suoi salottini di divanetti duri e striminziti, i suoi orrendi fiori di plastica nelle bottigliette della sprite sui tavolini degli spazi comuni e sulla tavola del desolato refettorio.
Non ho il coraggio di dirgli che cambieremo posto.
Deepak si è messo al nostro servizio ed abbiamo la netta impressione che lo sia da sempre.
La mattina, a colazione, io e Sobala abbiamo avuto un esplicito senso di casa, con domestico fidato cresciuto nei nostri stessi spazi.
Solo in Oriente mi capita di avere una peculiare sensazione di profonda famigliarità con persone che, di fatto, sono dei perfetti estranei ma che sento di conoscere da tempi lontani.
“Credo che la stanza che abbiamo visto sia decisamente migliore”, dico a Sobala, “ma…non so, non me la sento di andare via dall’hostél, loro (Deepak ed il fratello, non meno dimesso) sono così premurosi…”
“E’ proprio questo”, mi risponde lei, “adesso hai capito. Provo compassione per loro!”.
Sobala è di casta alta -discende da un antico lignaggio guerriero- in un paese dove la casta è tutto, dove si dà per scontato che le caste inferiori lo siano a tutti gli effetti, composte da persone in tutto e per tutto di serie b o di serie c.
Eppure, molte volte ho visto la sua anima vibrare di profonda umanità, quasi come se la sua usuale durezza talora si stemperasse con i più meritevoli.
“Va bene”, riprendo dopo un po’, “è deciso, restiamo all’hostél, per Deepak e per il fratello, hanno bisogno di lavorare, non ci pensiamo più!”.
Sobala fa un piccolo verso di approvazione e siede un po’ allarmata nella barchetta che procede sul lago. Sobala non sa nuotare. Ha visto per la prima volta il mare quando siamo stati insieme a Goa, alcuni mesi or sono. Sul palmo della sua mano è scritto chiaramente che morirà in acqua e dunque è sempre molto cauta e a volte esplicitamente timorosa in situazioni come questa.
Passiamo giorni moderatamente felici nell’hostél della compassione.
Deepak è sempre molto sollecito. Bussa alla porta ed apre anche senza il nostro permesso, un po’ impacciato con il suo vassoio in mano. È probabilmente incuriosito dalla nostra relazione. Non è l’unico. È più comune trovare uomini indiani che si accompagnano con donne occidentali che viceversa. Noi destiamo dunque una curiosità morbosa, soprattutto in India ma, sto avendo modo di vedere, anche qui in Nepal. Sono in genere gli hindu a nutrire questa curiosità spesso irritante. Ci è capitato diverse volte, in India, di essere avvicinati da un uomo che, senza troppi convenevoli, chiedeva a Sobala: ma tu che ci fai con un occidentale? Siete sposati? Sobala in genere non rispondeva ed io guardavo l’intruso con aria interrogativa e questo, come aveva improvvisamente invaso il nostro spazio, così soprassedeva e andava via.
Pokhara è quasi deserta in questo periodo dell’anno, a causa dei monsoni. È dunque languida e struggente nella sua malinconia economica.
Una mattina lasciamo la città per la montagna. Andiamo in un villaggio poco distante, Sarangkot e ci inerpichiamo per un sentiero aspro, fiancheggiato da baracche che vendono vestiti, scialli, khukuri (i coltelli dei temibili gorka, venduti in genere come souvenirs) o semplicemente bibite e snacks. Sulla strada incontriamo un tempietto minimale, a base quadrata, con una piccola cupola piramidale. Dentro c’è una statuetta decapitata di una dea, appena sotto un triangolo ricavato nel muro.
La statuetta, mi spiega Sobala, rappresenta la Shakti, l’energia femminile.
“E’ straordinario questo tempio”, mi dice, “è perfetto per la sadhana (pratica spirituale). Qui sicuramente c’è qualche sadhu che viene ogni giorno. È un posto che connette direttamente a Dio, raccoglie le vibrazioni dei mantra e le direziona verso l’alto”.
Ci sediamo all’interno. Ci si sta a malapena, in due, seduti. Sobala porta le mani alla bocca unite nello shank-mudra ed inizia ad intonare l’OM. Io la seguo ed in effetti la risonanza del tempietto è perfetta. Da fuori arrivano pochi rumori mentre noi, ora, sediamo semplicemente in silenzio. In compenso mi arriva, leggermente attutito, l’odore del mio corpo e di quello di Sobala ed i due odori si mettono comodi nel mio stato meditativo.
Sobala riprende ad intonare il mantra ed io la seguo, da bravo discepolo.
La nostra conoscenza è iniziata, difatti, in un contesto magisteriale. Lei era la mia maestra di yoga quando approdai a Varanasi, citta’ santa e malsana, quasi due anni fa.

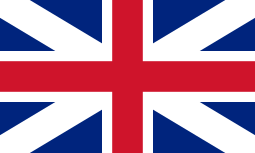 English
English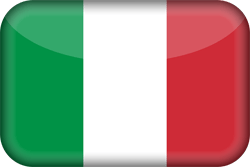 Italian
Italian